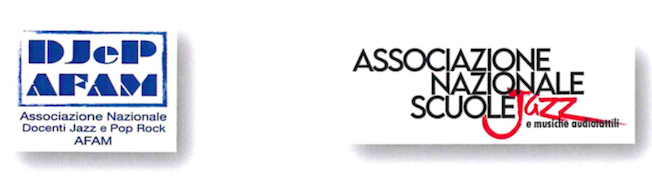L’Associazione Nazionale Docenti Jazz e Pop Rock dell’Afam e l’Associazione Nazionale Scuole Jazz e musiche audiotattili hanno siglato un protocollo d’intenti per ampliare e potenziare il sistema formativo. Che, in Italia, dà lavoro a oltre 100.000 insegnanti e coinvolge un milione di studenti
Con la seguente intervista, che ci hanno concesso con grande cortesia e disponibilita’ a quattro mani, Claudio Angeleri e Nicola Pisani, rispettivaente presidenti dell’Associazione Nazionale Scuole Jazz e musiche audiotattili e dell’Associazione Nazionale Docenti Jazz e Pop Rock dell’Afam, ci raccontano di piu’ di quello he rappresenta non solo un proocollo ma un cambiamento epocale nella promozione del jazz italiano e della didattica.
Da dove nasce l’esigenza di siglare questo protocollo?
Ci siamo sempre trovati d’accordo in merito ai grandi temi che riguardano la promozione e valorizzazione del jazz italiano, la necessità di riformare la normativa in materia di lavoro per i musicisti italiani, oggi troppo burocratizzata e complessa, fino alle specificità della didattica jazz che necessita di modalità e paradigmi differenti da quella convenzionale in quanto ha un DNA diverso, fondato sulla autografia musicale generata dall’improvvisazione e non sull’esecuzione di composizioni scritte da altri e trasmesse solo dai codici visivi della notazione.
Lo Stato e le istituzioni in generale che ruolo hanno ricoperto nel processo che ha portato al protocollo?
Per ora siamo ancora in fase elaborativa delle proposte anche se il MIC si è preso un anno di tempo per formulare i decreti attuativi della legge 106 di riforma dello spettacolo, peraltro già approvata ma che attende di essere operativa. Uno stallo ingiustificato in quanto le soluzioni sono state già ben evidenziate e formulate da diverse associazioni che riuniscono tutta la filiera dello spettacolo. Tuttavia, didattica e attività performativa sono trattate ancora separatamente mentre in altri settori la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro sono strettamente connessi. Si tratta della cosiddetta alternanza scuola-lavoro (oggi denominata percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, PCTO). “Personalmente confido molto nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha promulgato una legge, la 206, che valorizza i prodotti e gli operatori italiani, anche nel settore creativo” (Angeleri). Tuttavia, i festival, sebbene sostenuti anche da risorse pubbliche, sono ancora troppo appiattiti su proposte “di cassetta” invece di coinvolgere con maggiore curiosità progetti di artisti italiani ed europei il cui livello è altissimo. A livello nazionale una normativa più semplice e favorevole ai musicisti italiani certo cambierebbe le carte in tavola. “Da un punto di vista formativo è bene ricordare che l’intervento dello Stato nel Jazz è maggiormente rappresentato proprio dalla formazione sia nel settore accademico dell’AFAM che nell’attività del terzo settore. Ormai il Jazz è parte integrante dell’organigramma istituzionale dei Conservatori e ha contribuito in questi anni a mantenere alta l’attenzione verso i corsi accademici musicali” (Pisani)
Da quale stato di salute si parte, ad oggi, nei Conservatori? E quale gradiente si percepisce in base alle coordinate geografiche?
Per le scuole di musica e le associazioni del terzo settore la cui normativa le pone su un piano complanare all’ambito pubblico, riportiamo i numeri dell’indagine dell’Università di Bologna che parlano da soli: 100.000 docenti e 1.000.000 di studenti. Mentre specificatamente nel settore AFAM abbiamo ca. 60 dipartimenti distribuiti in tutta la penisola, con 550 docenti e 6000 studenti. Quindi potremmo confermare che i corsi di “scuola Jazz”, che comprendono tecnicamente il Jazz, la Popular Music e le Musiche Tradizionali, sono assolutamente attrattivi e senza particolari sbilanciamenti dettati dalla posizione geografica dei Conservatori. Mediamente la percentuale di iscritti è più o meno stabile in tutti i Conservatori e si attesta tra il 15% e 19%.
Quali sono mediamente, e con esempi, i contesti specifici dell’insegnamento di Jazz, Rock, e non solo, all’interno dei Conservatori?
Nelle scuole di musica del terzo settore esiste una sperimentazione didattica da più di mezzo secolo che è riuscita a creare le condizioni per la creazione delle cattedre jazz e delle musiche audiotattili nei conservatori. Il punto cruciale è che troppo spesso lo si dimentica. Questo protocollo intende al contrario riconoscere un processo che viene da lontano e continua ad alimentare in termini quantitativi e qualitativi le cattedre dei conservatori e di rimando quelle delle scuole di musica. Del resto, è impensabile che in 3 o 5 anni, che è la scansione dei diplomi Afam, si impari a suonare uno strumento. I migliori studenti provengono infatti dai percorsi formativi delle scuole di musica. Altra cosa che accomuna il terzo settore con i Conservatori è una attenta ricerca di percorsi pedagogici innovativi legati alla formazione nel jazz e non solo. Non dimentichiamo che le prassi improvvisative sono sempre esistite anche nella nostra storia musicale “tradizionale”, così come anche una particolare attenzione al concetto di ritmo, anzi il vero valore del Jazz è aver risvegliato delle prassi che, in successione, contribuisce ad una nuova visione pedagogica che ha valore trasversale con obiettivo il “come” si fa musica ancor prima del “cosa”.
Come verranno impattati enti accreditati e/o associazioni e tutte le realtà che offrono formazione?
A mio avviso non è opportuno replicare nel terzo settore il modello istituzionale dei Conservatori. Occorre invece definire una professionalità diversa attraverso la legge 4/2013 del MIMIT che parta proprio dalle specificità e bisogni di queste musiche già in parte descritte prima. Successivamente in base ai principi di sussidiarietà stabiliti dall’art. 118 della Costituzione si può creare anche in Italia – in diversi paesi europei è già in atto da tempo – un sistema misto – pubblico e terzo settore – che rappresenta la strada più sostenibile per la formazione musicale nel nostro paese che, non dimentichiamolo, è attanagliato da un enorme debito pubblico. Creare un collegamento tra terzo settore e Conservatori è indispensabile per ambedue gli ambiti. La riforma della scuola secondaria di II grado, i licei musicali, non ha dato i frutti sperati e soprattutto è insufficiente rispetto alla domanda educativa. Allo stesso tempo anche i corsi musicali delle scuole di I grado, scuole medie a indirizzo musicale, sono ferme al periodo del loro ordinamento, nella metà degli anni ’90. E ultima riflessione quando si parla di Liceo Musicale o Scuola Media a indirizzo musicale non si parla di Istituti votati a questo indirizzo ma solo di sezioni. Quindi aver trasformato i Conservatori in istituti accademici e universitari, con la L.508 del 1999 e seguenti, ha creato un notevole vacuum nella formazione musicale pre accademica che, in massima parte, è stata sopperita dal terzo settore più che dagli istituti di scuola secondaria a indirizzo musicale. Le esperienze, anche diverse in certi casi nei settori oggetto del nostro protocollo portano, a nostro parere, un comune arricchimento e scambio di prassi pedagogiche importanti.
Quali sono i risvolti e gli impatti per tutti quei musicisti che, scesi dal palco, prestano la loro opera didattica?
Non è detto che chi scende da un palco sia automaticamente un bravo insegnante. La didattica è una cosa seria che occorre approfondire e aggiornare costantemente. L’aspetto negativo purtroppo è il considerare la didattica un ripiego rispetto al concertismo, anche se stanno cambiando molte cose, in meglio, anche a livello culturale. Si è capito che didattica e concerti sono due facce della medesima medaglia. L’attività concertistica è un momento di auto formazione quando siamo didatti, la didattica diventa auto formazione quando saliamo su un palco.
Dal protocollo quali nuove opportunità per docenti e per studenti, futuri musicisti e/o docenti a loro volta, saranno prospettate?
Già il fatto di aver avvicinato due settori spesso lontani e antagonisti è di per sé un atto rivoluzionario. Quindi se il buon giorno si vede dal mattino non posso che aspettarmi grandi cose. Del resto, i numeri del terzo settore già dimostrano che l’insegnamento nelle scuole di musica è il principale ambito occupazionale per musicisti e neodiplomati. Chi può e deve fare sono le istituzioni ed in particolare i due ministeri della scuola e dell’università. Lo scorso giugno il MIM ha stretto un protocollo con la Fondazione Uto Ughi. Il punto cruciale riguarda il fatto che coinvolge solo la musica classica ed è quindi esclusivo e, mi permetto di dire a titolo personale, già vecchio in partenza. Bisogna includere tutti i contributi anche quelli delle musiche audiotattili come il jazz il pop il rock che proprio a livello pedagogico offrono delle risposte idonee e innovative ai bisogni di musica di oggi.
Oltre al protocollo di intesa, ci sono altre attività o iniziative prossime o future da tenere in considerazione e sostenere?
L’ANSJ sta allestendo il cartellone dell’International Jazz Day Unesco nel mondo della scuola con quasi cento istituti pubblici in tutte le regioni. Si chiama Jazz Mood Day ed è aperto anche ai contributi dei Conservatori. La DJeP è impegnata sia nella promozione del progetto ONMC, Orchestra Nazionale di Musica Creativa dei Conservatori, sia nello stimolare sinergie tra i diversi dipartimenti e lo stesso terzo settore per la condivisione e creazione di reti che possano dare spazio alla grande richiesta di formazione e ricerca e alla grande capacità progettuale e creativa del mondo del Jazz e della Musica Improvvisata italiana.